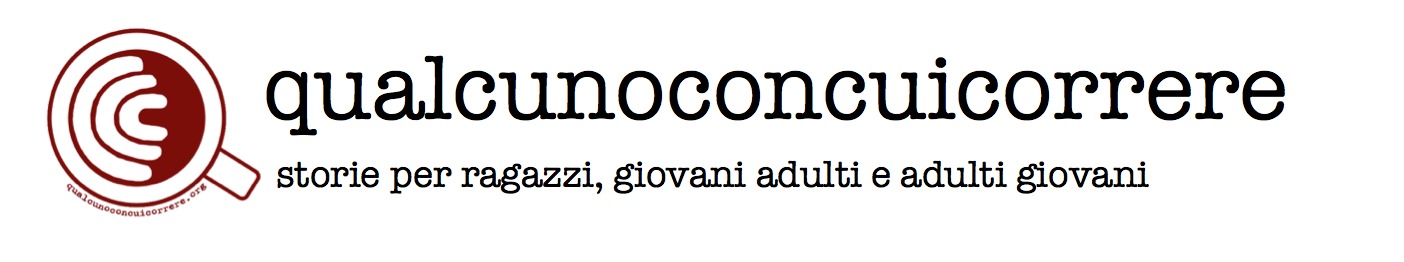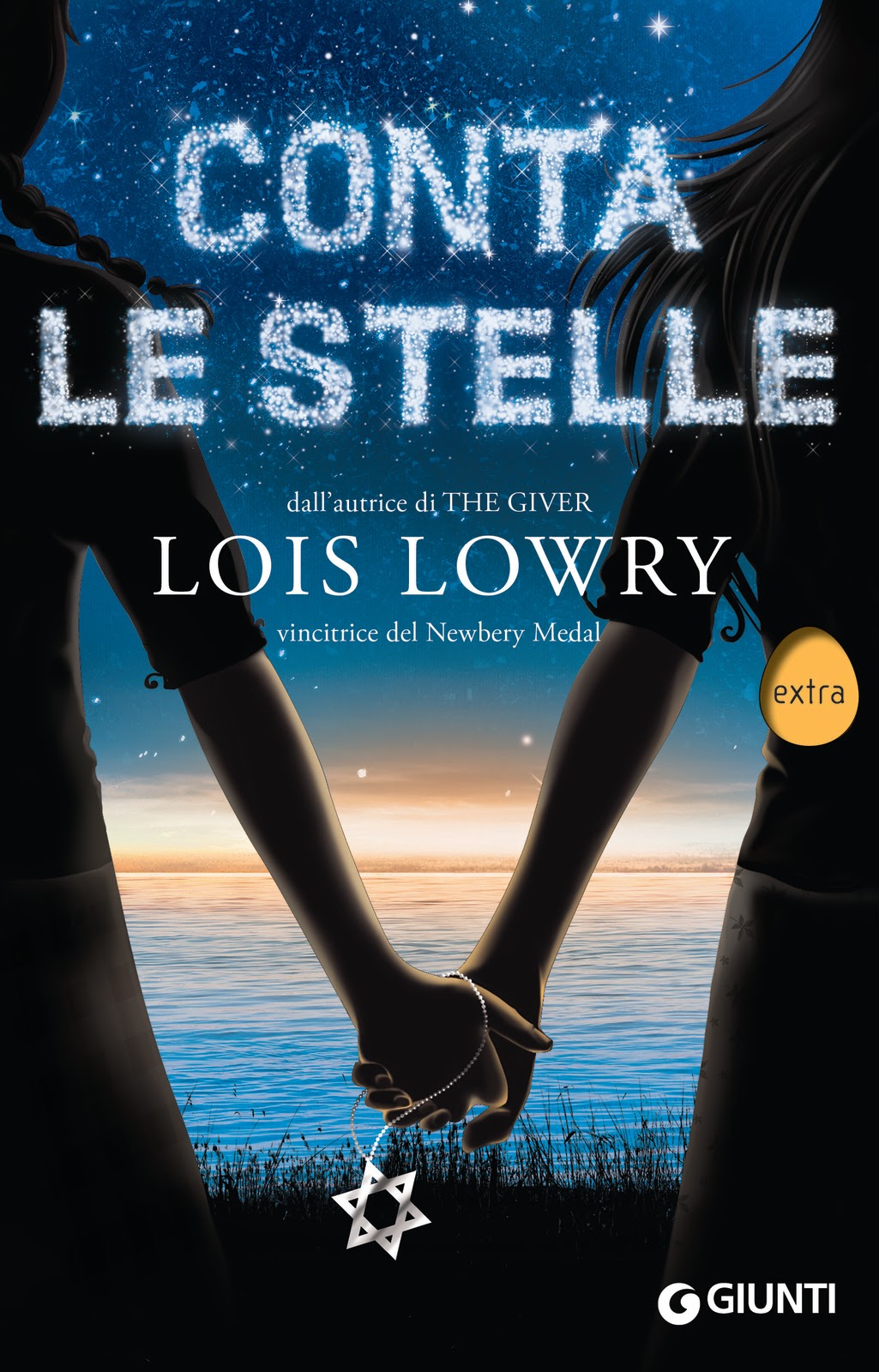Trovare le parole
“Quando sei colpito da una tragedia tutti scrivono: “Non ci sono parole”. Io ho pensato: “Abbiamo bisogno di trovare queste parole”
Lo scrittore israeliano racconta a Repubblica “Caduto fuori dal tempo”, il libro che nasce dalla terribile esperienza del figlio ucciso in guerra sei anni fa. “Il primo impulso a scrivere è stato la volontà di creare un movimento nella staticità e nel gelo che la morte impone a chi muore e a chi soffre”
di DAVID GROSSMAN
 David Grossman in un disegno di Tullio Pericoli
David Grossman in un disegno di Tullio PericoliCaduto fuori dal tempo.L’uomo che parte alla ricerca del figlio non sa dove sta andando. Lascia che siano le gambe a condurlo. Per giorni e notti gira intorno alla sua città. La sua andatura si fa sempre più caparbia, decisa, e il suo movimento crea una specie di campo magnetico che influisce sulla città e sui suoi abitanti. Chi forse attendeva che comparisse un uomo simile, deciso a sfidare il confine tra “qui” e “laggiù” solo in forza di un grande desiderio, è attratto da lui, incapace di resistergli.Così, notte e giorno, camminano il Duca fuggito dal suo palazzo e la riparatrice di reti da pesca, la levatrice e il ciabattino silenzioso, un uomo che annota freneticamente le cronache cittadine e un anziano insegnante che risolve problemi di matematica sui muri delle case. Da una finestra lontana li segue con lo sguardo un tipo collerico chiamato “Centauro”, bloccato alla sua scrivania e paralizzato dalla propria incapacità di ridar vita a suo figlio attraverso il racconto. I viandanti camminano uniti, cercando di avvicinarsi – per quanto possibile, per quanto sia concesso a un essere vivente – al luogo dove la vita e la morte si intrecciano.
Ora che ho il libro stampato davanti agli occhi, mi sento come se mi fossi svegliato da un lungo sogno, e per la centesima volta penso a quanto sia frustrante il tentativo di utilizzare parole del mondo dei vivi, di “qui”, per descrivere qualcosa che appartiene a “laggiù” e che, pur esulando dai confini della nostra coscienza e conoscenza, è così presente nelle nostre vite.
Durante l’intera stesura del libro ho avuto la sensazione che per parlare di “laggiù” fosse appropriato solo un grido animalesco, antecedente all’umanità, al linguaggio. O il pianto. Oppure un atto puramente fisico e del tutto inspiegabile: per esempio, una corsa senza meta fino all’esaurimento delle forze. O una camminata in cerchio, peregrina, anch’essa senza meta. O magari scavare una buca nel terreno e sdraiarvisi dentro ad aspettare, come hanno fatto i “viandanti” nel mio libro.
Eppure arriva un momento in cui si sente il bisogno di parlare. Perché è questa l’essenza dell’uomo: voler esprimere tutto “questo” e “laggiù” con parole, discorsi, scrittura, poesia.
E dopo aver inevitabilmente parlato e scritto e declamato, dopo tutto ciò, cosa ci resta se non rabbrividire, veramente inorriditi, per ciò che abbiamo fatto? Per aver dato a “questo” parole? Per aver preteso, con una traduzione mediocre e riduttiva, di rendere “laggiù” con i termini di “quaggiù”, di domare il caos, di trasformarlo in un’illusione effimera, in un’apparente consolazione?
Da quando ho perso mio figlio, ucciso in guerra sei anni fa, ho sentito di dover fare qualcosa. Di tentare un altro passo per arrivare “laggiù”, nel cuore di ciò che è successo. Cercare di capire, intuire. Dopo tutto, ho pensato, qualcosa di me, di mio, è già lì, quindi anche “laggiù” non mi è completamente estraneo…
Ricordo anche di aver pensato che, se il destino mi aveva mandato in quella terra di esilio, per lo meno avrei cercato di tracciarne una mappa, per quanto possibile e nell’unico modo che ho a disposizione: con la scrittura e il racconto. Avevo la flebile, patetica speranza che attraverso la scrittura avrei potuto trovare qualcosa – un cammino, una fessura, un contatto… Ritenevo di poter ammorbidire, rendere flessibile, far fluire un po’ di calore in qualche punto remoto, al limite estremo dell’universo, del nulla assoluto, dell’ermetico. Oppure, accidentalmente, per puro caso, avrei inventato una frase magica, una sorta di “Apriti Sesamo” che all’improvviso avrebbe incrinato la scorza impenetrabile del nulla e forse allora, per un istante, avrei visto…
Naturalmente non ho visto quella “Terra di laggiù”. Però è successa un’altra cosa: l’esperienza dei vivi che toccano la morte, che sono toccati dalla morte, un’esperienza che un tempo mi sembrava sostanzialmente gelida, paralizzante e inanimata, nel corso della scrittura (e forse a causa di essa) si è rivelata complessa e articolata, dinamica e in costante evoluzione, venata di intimità, di nostalgia, di tristezza, di pienezza di vita e di vuoto di vita.
E dal momento in cui ho iniziato a scrivere, le frasi sono affiorate sotto forma di poesia, con il ritmo e il respiro della poesia. Non è stata una scelta. Non è stata una “decisione”. Un attimo prima non sapevo che sarebbe stato così, ma mentre scrivevo le parole arrivavano quasi sempre sotto forma di poesia. Ogni giorno mi sedevo a scrivere prosa, e scaturiva poesia. Perciò ho capito: la poesia è il linguaggio del mio dolore. Posso solo supporre per quale motivo le cose siano andate così. Forse perché la poesia è più vicina al silenzio. O perché l’impulso di scrivere arrivava quasi sempre insieme a quello di non scrivere e alla sensazione che, se proprio dovevo dire qualcosa, quella cosa doveva essere esile, quasi evanescente: poesia.
Ma queste sono spiegazioni successive, un tentativo di trovare un senso a ciò che probabilmente un vero senso non ha. Quando cerco infatti di capire perché io abbia scritto il libro in questo modo, ricordo soprattutto una sensazione fisica mai provata in precedenza: come se una forza mi piegasse il polso costringendomi a interrompere la frase proprio in quel punto, a metà strofa, a metà di un respiro, e obbligandomi a passare alla riga successiva.
Voglio aggiungere un’altra cosa a proposito della stesura di questo libro: il primo impulso a scriverlo è nato dalla volontà di creare un movimento nella staticità assoluta. Nell’immobilità e nel gelo totale che la morte impone non solo a chi muore ma anche, in un certo senso, a chi soffre per quella morte. E, ripeto, posso immaginare – soltanto immaginare – di avere cercato non solo delle parole ma anche il modo con cui quelle parole divenissero movimento. Di aver cercato un ritmo che mi desse la sensazione di potermi ancora muovere, di essere libero dinanzi a ciò che minacciava di paralizzarmi e pietrificarmi.
E man mano che la scrittura procedeva capivo ciò che ha capito Centauro nel libro quando dice:
Ed è la mia anima,
a essere falciata
nel gelido biancore
fra una parola
e l’altra. Sono
io,
io a fremere come una preda
nelle fauci dell’assoluto.
Combatto per me stesso,
solo per la mia anima
contro ciò che annichilisce
offusca
e sminuisce.
Tutta la mia vita
ora,
tutta la mia vita
in punta di penna.
Ecco cosa mi ha dato la scrittura: la sensazione di non essere una vittima passiva e impotente di ciò che è accaduto. Ovviamente non potrò cancellare il passato e non potrò riportare in vita il mio caro e neppure far muovere nulla in lui. Ma non sarò paralizzato e immobile contro l’arbitrio che mi ha colpito. E un’altra cosa ho imparato in questi anni: in certe situazioni l’unica libertà che ha un uomo è quella di formulare la propria storia con le proprie parole, non con quelle dettate da altri.
So quanto sia piccolo l’atto creativo dinanzi alla morte. Quanto l’impulso di creare, inventare, immaginare, insistere a cercare la parola giusta, l’unica, sia senza speranza. E, in generale, so quanto sia fragile l’illusione umana che questo sforzo di precisione abbia un qualche significato “obiettivo” in un mondo indifferente, arbitrario e inspiegabile.
Eppure, mentre scrivevo, avevo spesso la sensazione che se avessi trovato la parola giusta avrei in qualche modo compiuto una piccola riparazione; avrei creato un luogo – o addirittura una casa – per me e forse anche per chi leggerà il libro, in un mondo divenuto quasi interamente terra di esilio.
Del risultato finale, del libro terminato come opera che va incontro al suo destino, testimonieranno gli altri. Io posso solo dire che mentre lavoravo a questo libro sentivo – in contrasto con le circostanze in cui è stato scritto – di essere fortunato perché potevo dare a tutto “questo” parole.