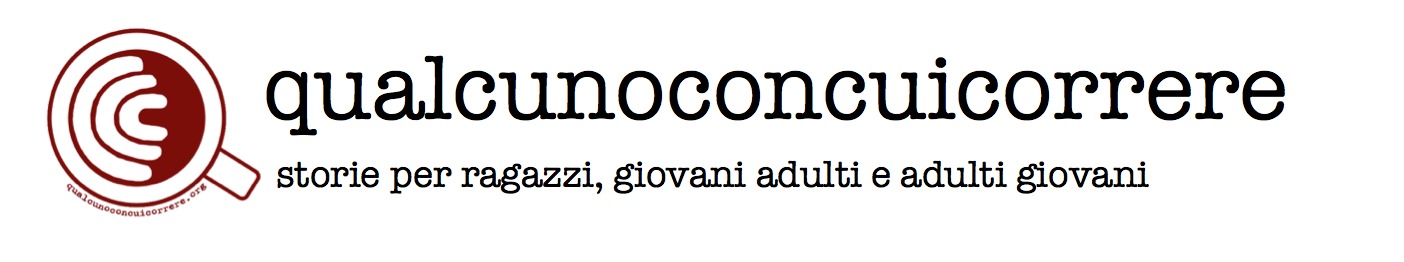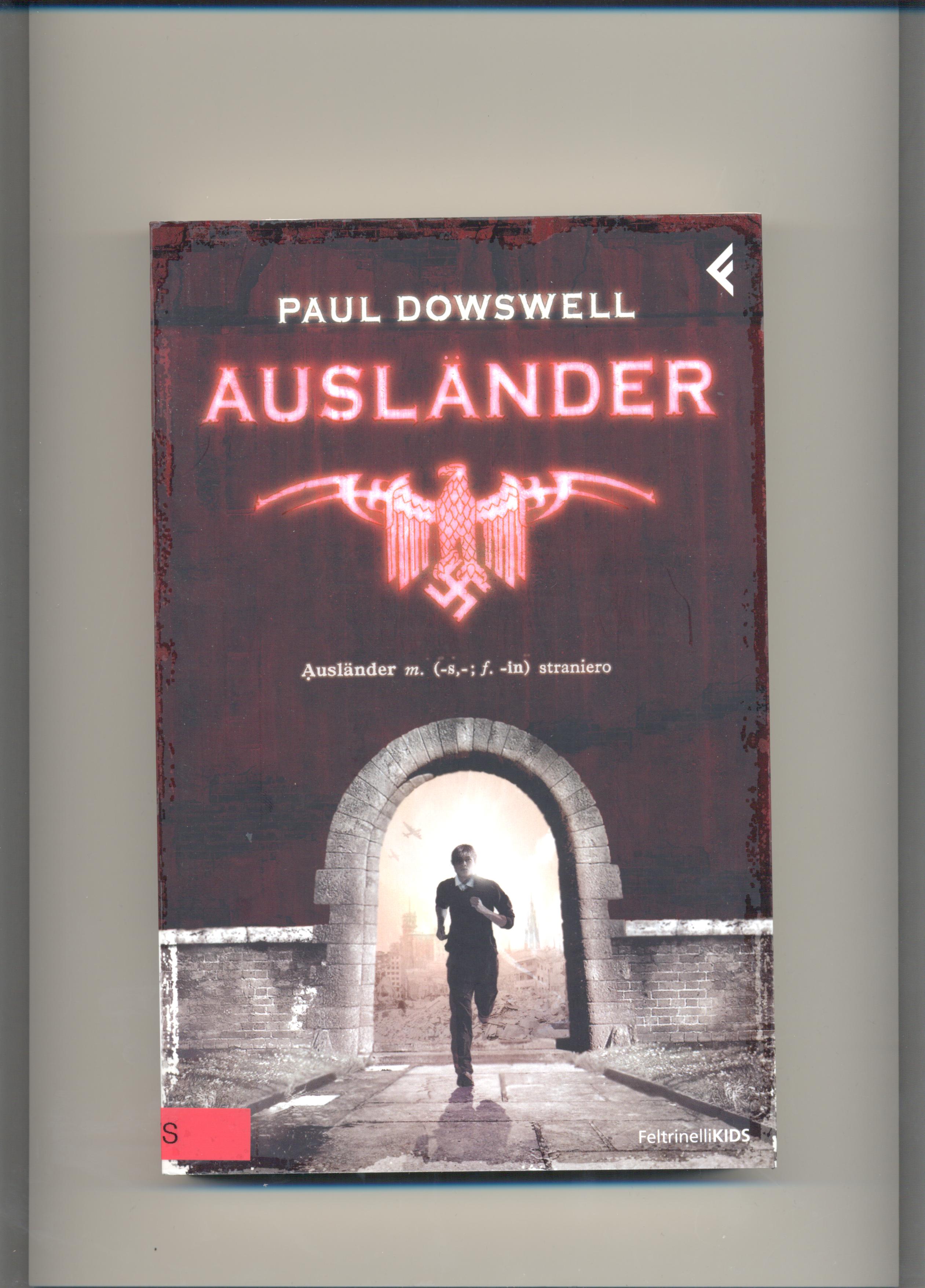John Green, Città di carta
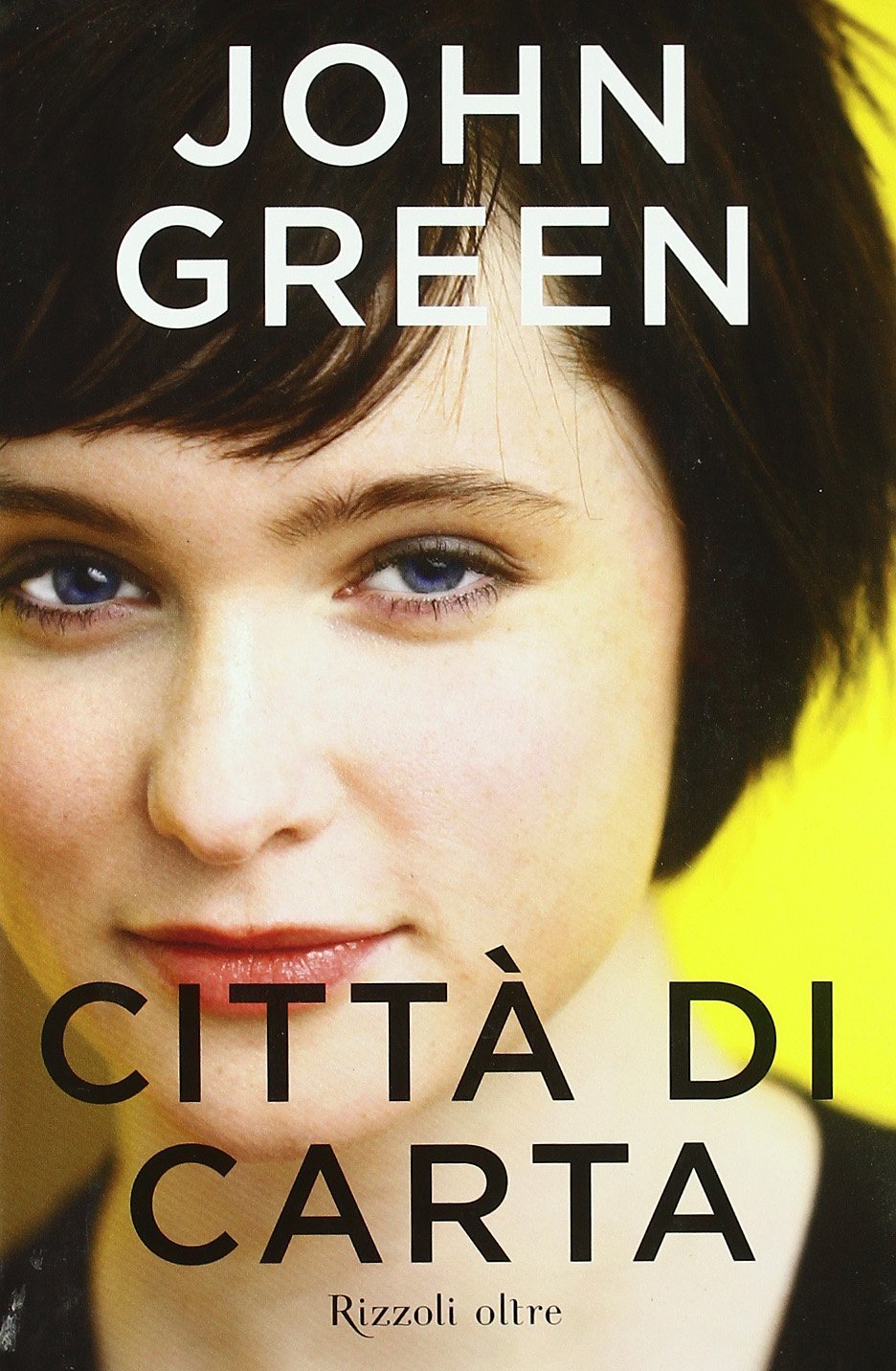
Avere la consistenza della carta significa, in questo romanzo, possedere due sole dimensioni, essere piatti e superficiali.
Orlando, ad esempio, è una città di carta: guardandola dall’alto, si scorgono persone il cui unico desiderio appare quello del possesso: “ragazzini di carta che bevono birra che qualche cretino ha comprato loro in qualche discount di carta.”
Nella paper town Orlando vive Quentin, detto Q: ultimo anno di scuola, ottimi voti, carattere tranquillo e futuro già scritto, almeno fino a quando Margo Roth Spiegelman, la sua vulcanica vicina di casa, non si presenta in camera sua in piena notte per trascinarlo in una irresistibile spedizione punitiva notturna.
La mattina seguente, la ragazza scompare. Non è la prima fuga di Margo: in passato la ragazza è già fuggita di casa, ma i pochi, frammentari, indizi disseminati stavolta non fanno presagire niente di buono. E la sfida di Q , l’ossessione che lo trasforma in un novello Achab nel tentativo di cercarla si trasforma in una sfida con l’obiettivo di conoscere la vera Margo, al di là dell’immagine idealizzata, e pertanto superficiale, che ne ha avuto fino ad allora. Del resto il cognome Spiegelman in tedesco rimanda alla parola “specchio”, come ad alludere al fatto che ognuno dei protagonisti (Q, ma anche gli amici e le amiche) vede in Margo qualcosa di se stesso.
Il terzo romanzo di John Green non aggiunge molto, è opportuno dirlo subito, all’universo narrativo dello scrittore americano: Margo Spiegelman deve qualcosa allo straordinario personaggio di Alaska Young, laddove Q e i suoi amici Ben e Radar rimandano col pensiero agli omologhi dei due romanzi precedenti. L’immancabile vezzo nerd, dopo la passione per le ultime parole dei grandi personaggi della storia in Cercando Alaska e la mania degli anagrammi in Teorema Katherine, stavolta consiste nell’ossessione per l’aggiornamento continuo di un sito web Wikipedia-style.
Quanto all’ambientazione, poi, non ci si discosta affatto da Teorema Katherine: dalla vita nella scuola superiore, scandita da routine quotidiane ed appuntamenti annuali, come il ballo di fine anno, alla digressione on the road.
Ciononostante, John Green ha la capacità indiscutibile di insinuare in un contesto tanto riconoscibile quanto prevedibile, una fitta e complessa (basti pensare che l’espressione Città di carta assume nel romanzo tre accezioni differenti) trama di significati ulteriori, tanto metaforici quanto scoperti, di riferimenti culturali alti (Whitman, Melville) e di sguardi corrosivi all’America degli anni Zero. E il merito, altrettanto evidente, di affidare riflessioni profonde a ragazzi normalissimi senza perdere affatto credibilità.
Forse è più come hai detto prima, che dentro di noi si sono aperte delle crepe. Ognuno all’inizio è una nave inaffondabile. Poi ci succedono alcune cose: persone che ci lasciano, che non ci amano, che non capiscono o che noi non capiamo, e ci perdiamo, sbagliamo, ci facciamo male, gli uni con gli altri. E lo scafo comincia a creparsi. E quando si rompe non c’è niente da fare, la fine è inevitabile. Però c’è un sacco di tempo tra quando le crepe cominciano a formarsi e quando andiamo a pezzi. Ed è solo in quel momento che possiamo vederci, perchè vediamo fuori di noi dalle nostre fessure e dentro gli altri attraverso le loro.
MB