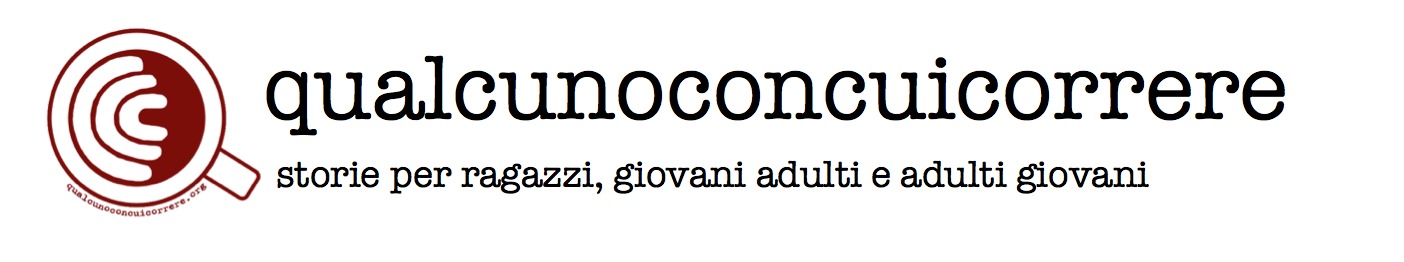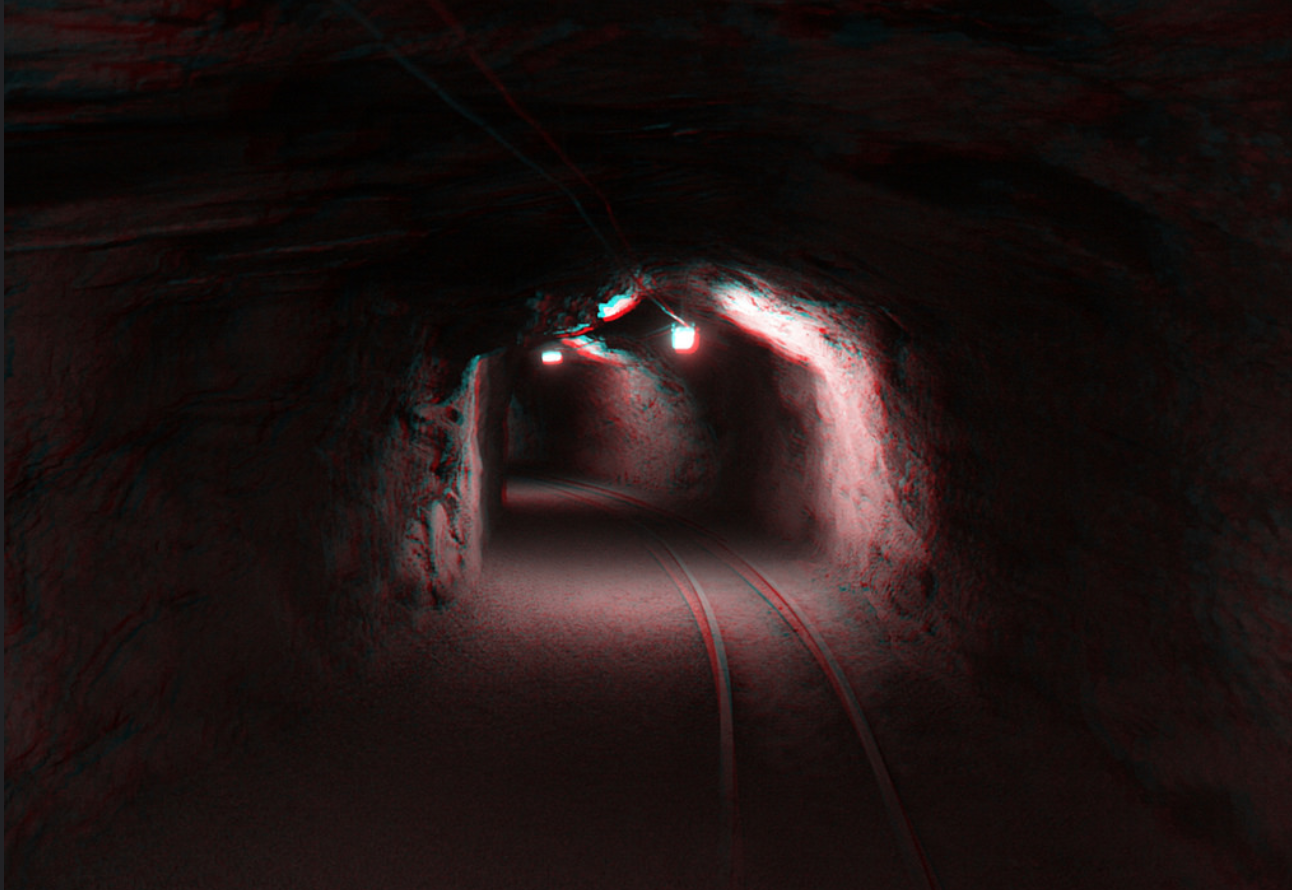Thomas Mann, Morte a Venezia

Durante il suo soggiorno a Venezia nel maggio 1911, Mann, nel breve saggio Sull’arte di Richard Wagner, si prefigurava il capolavoro del XX secolo in un’opera d’arte che non cercasse “la sua grandezza nel colossale barocco e la sua bellezza nell’ebbrezza – una nuova classicità, mi sembra, deve venire”. Non esente da suggestioni biografiche goethiane, l’amore del poeta settantenne per la diciassettenne Ulrike von Levetzow “una storia maligna, grottesca, inquietante”, l’intreccio tragico-novellistico della Morte a Venezia prende corporea forma a partire dalla sofferta consapevolezza del dissolversi della dignità artistica nella voluttà di amore e morte. E la Venezia lagunare, fatiscente e maleodorante, che è fortunata ambientazione della vicenda, si configura come scelta quanto più calzante del compiersi della vicenda terrena di Aschenbach, soprattutto per l’antinomia coesistente del putrido e del monumentale, con le sue facciate maestose dei palazzi antichi. A Venezia si consuma il suo sacrificio; sedotto da Thanatos, rivestito dalle ingannevoli sembianze di Eros, l’abbandono al caos, interiore ed esogeno, è tale da provocarne la morte sulla spiaggia del mare, dopo gli sguardi insistenti all’Hotel des Bains. Perduta quell’integrità dedita al decorum e alla compostezza, si insedia vittoriosa l’irrequietezza, il turbamento per l’irrompere di ebbre potenze distruttrici nella sua coscienza, prima incuriosita poi inquietata e infine sconvolta dalla presenza di Tadzio. L’adolescente “dal volto pallido e gentilmente assorto, la linea schietta del naso, la bocca vezzosa, l’espressione soave e divina di gravità, che ricordano le sculture greche di epoca aurea” – descrizione prima del giovane – incarna quella soave bellezza che ha in sé tendenze degradanti e decadenti, che già rimanda alla sua caducità. Malgrado l’avvenuta perdita dell’aureola di Aschenbach, egli mantiene una raffinatezza tale da rivelarsi portavoce ideale del recupero culturale dell’eros socratico, che si insinua nelle sue dinamiche analitico-introspettive come alla ricerca di un’estrema interpretazione, forse in un primo momento autoassolvente, del suo interesse per Tadzio. Aschenbach è pienamente impregnato delle implicazioni del vivere nel suo tempo e nella società borghese al tramonto, mosso da spinte in inconciliabile antitesi che lo vedono risolvere la profonda contraddizione che lo anima nell’unica risultante possibile: la morte. V’è consapevolezza del percorso che sta compiendosi da parte di von Aschenbach, che tuttavia pare inerte dinanzi al tragico sfacelo imminente. E’ forse solo un’apparente mancanza di volontà di ribellione, è forse accettazione, benché sofferta, dello sgretolarsi delle sue certezze, dolore che condivide con la sua epoca, ancor più è consapevolezza che l’uomo sente limitanti i confini apollinei, uomo che è anche essenza dionisiaca, degli impulsi estetici. E la riflessione portante che la bellezza sia l’unica forma dello spirito conoscibile, poiché visibile, viene presto confutata dall’affermazione che l’arte stessa – la sua, in questo momento – non può prescindere da Eros per conoscerla e conoscersi; tuttavia l’amore è anche abbandono all’estetica, alla sensualità, all’impulso che può, e anzi sovente tradisce la propria direttrice morale. Aschenbach non può che soccombere alla decadenza artistico-morale incombente, dove i principi illuminanti del sapere e dell’agire classico, desacralizzati, cedono ad un al di là irraggiungibile, come il braccio proteso di Tadzio verso l’orizzonte pare suggerire.
Chiara Principe
free photos from Pixabay