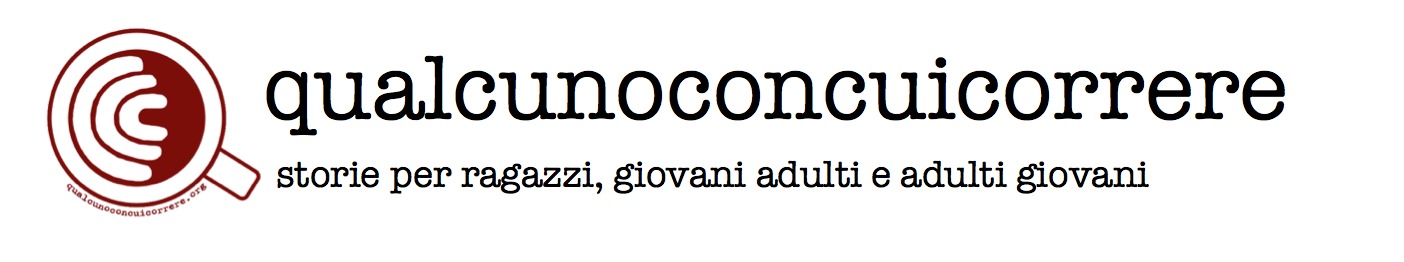Dieci domande a Gabriele Clima su “Continua a camminare”.

Come nasce l’idea di questo libro?
Il libro nasce da due articoli letti su un giornale qualche anno fa. Il primo raccontava di Spozhmay (diventata Fatma nella storia), una bambina afghana che si era consegnata ai soldati del posto di controllo presso il quale avrebbe dovuto farsi esplodere; il secondo di Abu Malek (nella storia Abèd, il fratello di Salìm), che a Damasco raccoglieva i libri dalle case bombardate. Le notizie mi colpirono, entrambe, forse più quella di Spozhmay, e dev’essere per questo che, come alcuni mi hanno detto, a Fatma ho concesso più spazio nella storia. Il personaggio di Salìm, invece, nasce da un’esigenza narrativa: mi serviva una figura in cui i miei lettori, adolescenti, potessero riconoscersi: Abu, nella realtà, è troppo vecchio, ha più di trent’anni, perciò ho pensato di affiancargli un fratello più piccolo, Salìm appunto. Il quale, alla fine, ha assunto in questo modo più forza narrativa, perché di fatto, nella storia, rappresenta l’eredità morale e intellettuale del fratello, il passaggio del testimone di un attivismo civile e culturale alle nuove generazioni.
Quanto dei due protagonisti è vero e quanto è romanzato?
Nella storia quasi tutto è romanzato. Questo perché erano pochissime le informazioni a mia disposizione. I giornali non avevano riportato quasi nulla, né su Spozmay né su a Abu Malek. Di quest’ultimo sapevo della biblioteca clandestina, dei libri che cercava fra le case bombardate di Damasco, dei volumi recuperati fino a quel momento (più di diecimila), e dell’amico che con lui stava sistemando e catalogando i libri nella biblioteca; di Spozhmay sapevo ancora meno, ovvero che al martirio era stata spinta dal padre e dal fratello, e che si era consegnata ai soldati a causa di quel fiume – di cui forse non era a conoscenza – che le aveva sbarrato il passo. Una seconda fonte in verità azzardava un’altra ipotesi, ovvero un malfunzionamento nel meccanismo di innesco della cintura esplosiva. Ho scelto la prima, narrativamente più intrigante perché quel preciso istante, nella storia, diventa confluenza del percorso esistenziale che Fatma compie fino a lì.
Come hai fatto a documentarti sulla situazione siriana, sull’ISIS, su Raqqa?
Il lavoro di documentazione è stato molto lungo. Non sono mai stato in Siria, né in tempo di pace né in tempo di guerra, e non conoscevo la cultura islamica, almeno non in modo approfondito. Ho letto molto, articoli, dossier, cronache di viaggio, libri sull’Islam, sull’interpretazione del Corano (che è di fatto il punto nodale della vicenda di Fatma), e ho visto film, documentari, perfino video su YouTube dove ho trovato materiale prezioso (arabo e inglese per lo più) sull’addestramento militare in quelle zone e sulla formazione dei giovani kamikaze delle organizzazioni terroristiche. Un lavoro che ha richiesto alcuni mesi, e che si è avvalso della collaborazione con alcuni giornalisti e scrittori siriani e libanesi.
Perché hai scelto di presentarci i due protagonisti alla fine del loro percorso, e andare a ritroso con il flashback?
A dire la verità, quando ho cominciato a impostare il lavoro, avevo previsto di raccontare la storia in modo molto diverso. Le vicende di Fatma e di Salìm dovevano addirittura essere narrate quasi separatamente, all’interno di una griglia che non le intrecciasse in modo così serrato. Poi, mentre davo forma al materiale raccolto, mi sono reso conto che quel che mi premeva non era tanto ricostruire le vite dei personaggi le cui storie mi accingevo a raccontare, quanto sondare le ragioni che li avevano condotti fino a lì. Ovvero i ‘perché’ mi interessavano molto più dei ‘cosa’. Perciò ho seguito quella strada regolando il mio orologio sul momento presente, e procedendo a ritroso, appunto, alla ricerca dei perché di ognuno. E siccome i perché si intrecciano, sempre, indipendentemente dal luogo e dal momento storico, ecco, ho intrecciato a doppio filo le vicende. Spero che questo sia passato anche al lettore.
Il libro è incentrato sulla ripetizione della formula “Continua a camminare”. È una metafora del non arrendersi? O della vita in generale?
Caspita, sarei tentato di rispondere “Certo, è esattamente quello che volevo significare”. In realtà ‘Continua a camminare’ non è stato pensato a tavolino. È venuto da sé, con la storia, anzi, dalla storia. Io ho messo in scena un viaggio (di Fatma e di Salìm), che è di fatto un viaggio esistenziale, un percorso di vita; in un viaggio così ogni cosa diventa metafora di qualcos’altro, ed è questa in fondo la bellezza della letteratura, soprattutto quella di formazione, raccontare qualcosa da cui emergano significati differenti a seconda del lettore che, quel viaggio, idealmente compie. Perciò sì, ‘Continua a camminare’ potrebbe certamente essere metafora del non arrendersi e della vita in generale, ma è il lettore a stabilirlo, non lo scrittore. Del resto, nella storia, ‘Continua a camminare’ assume significati differenti a seconda delle persone a cui viene rivolta: per Salìm ‘Continua a camminare’ è una necessità, è il solo modo per sopravvivere alla guerra; per Fatma ‘Continua a camminare’ è un ordine, un destino, al quale – sembra – non le è possibile sottrarsi; per entrambi, alla fine della vicenda, ‘Continua a camminare’ si trasforma in una possibilità, in un’altra storia che si apre nel momento stesso in cui il libro si chiude. Una metafora è sempre (o almeno così dovrebbe essere) qualcosa che emerge da chi ascolta, non da chi parla.
Abèd dice che “I libri salvano la vita”. Lo pensi anche tu?
Non solo lo penso, ma arrivo a scrivere ‘I libri fermano i kalashnikov’. Frase forte, una provocazione naturalmente, ma che rimanda a una realtà che mi pare incontestabile: non sono le guerre a vincere le guerre. Se ci pensi, è da millenni che noi uomini muoviamo guerra a paesi in guerra, creando altri conflitti che cerchiamo di sedare con conflitti più complessi. Il solo risultato è che le guerre si moltiplicano, modificando gli assetti politici, economici e sociali e creando voragini che poi non è più possibile sanare. Se proviamo a ragionare nel piccolo, nel quotidiano, se pensiamo a un nucleo familiare, vediamo chiaramente come un conflitto non possa mai essere appianato con un altro conflitto, con la prepotenza, con la prevaricazione, con la voce grossa, indipendentemente dalle parti in gioco. E se non funziona nel piccolo, perché dovrebbe funzionare nel grande? Perché dovrebbe essere diverso nei contrasti fra nazioni? Aprire un dialogo, invece, creare ponti, gettare le basi per un reale scambio di pensiero, mediare, costruire relazioni (non muri), questa è l’unica via. Ma lo si può fare solamente attingendo a quella preziosissima risorsa che è la nostra eredità culturale, l’istruzione, lo sviluppo del pensiero, i libri, in una parola. E dunque, per risponderti, sì, i libri salvano la vita.
Discutendo tra di noi, abbiamo notato che – confrontando le famiglie di Fatma e di Salìm, si nota che le madri sono simili, presenze silenziose ma positive, i padri piuttosto diversi, i fratelli proprio l’opposto. È voluto questo gioco tra simmetria e asimmetria?
Il gioco di simmetrie è inevitabile. Nel romanzo ho tratteggiato tipologie di Islam molto differenti; c’è l’Islam radicale della famiglia di Fatma; quello moderato della famiglia di Salìm; c’è un Islam storicamente inedito, l’islam non praticante, che nella storia trova il suo rappresentante nel nonno di Fatma. La simmetria (e asimmetria) dei ruoli viene come conseguenza, e segue gli schemi di questi modi a volte contrapposti di vedere le cose. A partire dalla condizione della donna e dal suo peso nelle dinamiche familiari: la madre di Fatma, silenziosa e discreta, si muove all’interno di un pensiero integralista che le sottrae, a tutti i livelli, ruoli e diritti; la madre di Salìm, anch’essa silenziosa e discreta, ha però facoltà di esprimere liberamente le sue idee, e di fatto ha un peso consistente sulle scelte e nelle questioni di famiglia. Dall’altra parte, il padre e il fratello di Fatma sono al servizio della causa fondamentalista, e questo li rende del tutto simili, quasi interscambiabili, nell’intenzione e nel pensiero; al contrario, il padre e il fratello di Salìm appartengono ad un pensiero libero e moderno, nelle azioni e nelle idee, tanto che Abèd può addirittura opporsi al volere di suo padre arrivando al contrasto che caratterizza il loro difficile rapporto. Simmetrie e asimmetrie, come in qualunque sistema di relazioni complesse, se lo si guarda da vicino.
In tutto il romanzo ciò che fa la differenza tra chi è perduto e chi non lo è è la capacità di riconoscere la bellezza: nei libri, nelle rondini, nelle piante, nella musica, nella poesia. È questo il messaggio di speranza che vuoi trasmettere con il libro?
In realtà, esattamente come detto per le metafore, la mia unica intenzione è raccontare una storia, senza alcun messaggio, senza alcun insegnamento nascosto fra le righe. Anzi, questo dovrebbe essere l’unico obiettivo di un libro e, in generale, di uno scrittore. Detto ciò, è inevitabile che ogni libro trasmetta un modo di guardare la realtà, una visione delle cose che appartiene allo scrittore, e che può essere legittimamente interpretabile come ‘il messaggio della storia’. Nel caso di questo libro sì, la mia visione è esattamente questa, la bellezza – e la capacità di riconoscerla – come ‘guida’ che permette di non perdersi. È la bellezza che consente a Fatma di vedere la sua luce dentro il buio, ed è la bellezza che consente a Salìm di vedere la sua strada nascosta nella sabbia. Credo che l’uomo sia attratto per natura dalla bellezza, i bambini, in particolare, che tendono alla bellezza come l’ago di una bussola tende al polo magnetico terrestre. L’importante è continuare a cercarla, a perseguirla, a percepirla, da qualunque forma di bellezza si sia attratti, dalla più complessa (quella artistica) alla più elementare (quella della vita di ogni giorno, che poi in verità tanto elementare non è).
I due protagonisti sono un profugo e un’attentatrice suicida, ma sono totalmente diversi dalle immagini mentali che abbiamo di questi due ruoli. Volevi distruggere gli stereotipi?
Direi proprio di sì, ma anche questo non è stato studiato a tavolino. La mia storia in fondo cerca di indagare nelle dinamiche che costituiscono i fenomeni sociali delle migrazioni e del terrorismo, ma quel che fa alla fine è restituire al lettore ‘persone’, non ‘fenomeni’. E questo implica un totale cambio di paradigma, perché nel momento in cui, sotto la lente, hai individui e non migranti, nel momento in cui hai persone, hai sogni, hai paure, hai illusioni, hai rabbia, hai dolore, hai vite, padri, madri, allora la tua indagine si fa più articolata; e ti accorgi che migrante non vuol dire clandestino, che musulmano non vuol dire terrorista, che islam non vuol dire integralismo. Se la cintura che Fatma porta in vita la rende a tutti gli effetti una terrorista, nel momento in cui conosci la sua storia ti accorgi che non è così, anzi, è l’esatto opposto. E lo sarebbe perfino se, alla fine, Fatma si facesse esplodere, perché anche in quel caso prima che carnefice sarebbe vittima. Ma di questo puoi accorgerti solo se osservi l’uomo, non l’immagine preconfezionata che gli altri ti offrono di lui.
Abbiamo discusso molto fra di noi del finale e lo abbiamo trovato aperto. Qualcuno ha detto che avrebbe voluto vedere i due ragazzi arrivare in Europa, qualcun altro ha detto che così è più realistico, perché non tutti ce la fanno. Tu come ti sei posto nei confronti del finale di questa storia? In generale, che ne pensi del fatto che spesso gli adulti ritengono doveroso il lieto fine nei libri per ragazzi, mentre i ragazzi talvolta non sentono lo stesso bisogno?
Non amo il lieto fine a tutti i costi. Se è coerente va bene, se la storia confluisce in una qualche tipo di risoluzione armonica che salvi tutti quanti perché no, ci sta anche il lieto fine. Ma è la storia a sceglierlo, non lo scrittore, perché una storia segue dinamiche complesse e in parte autonome (una è proprio la coerenza), che uno scrittore, alla fine, non può ignorare. Io personalmente adoro i finali aperti, né lieti né tristi, dunque, ma aperti, in cui il lettore sia libero di scegliere se unire i fili che ho tessuto nel corso della storia o lasciarli lì, pendenti, perché è esattamente quel che accade nella vita. Nella vita una storia non si chiude mai del tutto, lascia sempre strade aperte, vie possibili, percorsi alternativi; siamo noi a decidere quale imboccare o quale no, e quale direzione dare alla storia che, a quella, seguirà. Nel caso di questo libro, be’, di fatto sappiamo tutti come può finire il viaggio di Fatma e di Salìm. È storia nota, è storia di ogni giorno: sappiamo che alcuni ce la fanno e altri no; che alcuni muoiono, in mare o nel deserto, e altri riescono invece ad arrivare fino qui, per poi magari proseguire il viaggio verso altre destinazioni. Ecco, nel caso di Fatma e di Salìm lo lascio scegliere al lettore; col mio finale aperto gli affido, idealmente, le sorti di tutti quei migranti che stanno viaggiando in questo momento alla volta dell’Europa. Sarà il lettore a decidere se dare loro un’opportunità oppure no, a decidere, nel prossimo futuro, nel pensiero prima che nei fatti, se fermarli alzando un muro o lasciarli proseguire.
Rita, Viola, Giada, Giulia, Aurora, Sofia, Andrea